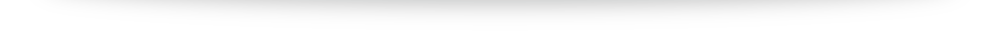Mobbing orizzontale: il datore si può rivalere sul dipendente autore delle persecuzioni.
Quando parliamo di ‘mobbing’ (dal verbo inglese “to mob” che significa “assalire, assaltare”) pensiamo a quelle situazioni in cui il datore di lavoro si comporta male nei confronti di un proprio dipendente, emarginandolo, mortificandolo e umiliandolo con atteggiamenti ripetuti, anche silenziosi e non necessariamente plateali, fino a spingerlo a rassegnare le dimissioni.
Ove questi atteggiamenti siano più sporadici, ma comunque invasivi e tali da creare un disagio a chi li subisce sul luogo di lavoro, parliamo invece di ‘straining’ (dal verbo inglese “to strain” che significa “tendere”, “mettere sotto pressione”, “stringere”).
Quindi la differenza fondamentale tra lo ‘straining’ e il ‘mobbing’ consiste nel fatto che mentre nel primo caso siamo in presenza di azioni sporadiche i cui effetti sono continui nel tempo (oppure una azione unica e isolata), nel secondo è fondamentale la continuità delle azioni vessatorie.
Attenzione però che questi atteggiamenti persecutori non sono sempre posti in essere dal datore di lavoro, ma anche tra colleghi di lavoro e ciò molto più spesso di quanto non si creda. In questi casi si parla di mobbing orizzontale o straining orizzontale.
Le statistiche sostengono che in Italia questo tipo di mobbing non sia ancora radicato come in altri Paesi, ma in realtà con la crisi occupazionale di questi ultimi anni la situazione sta cambiando. Le difficoltà a trovare un lavoro e la voglia di far carriera possono favorire un’insana competizione tra colleghi che può condurre ad azioni aggressive e mobbizzanti.
In una recente Sentenza, la n. 7097/18 del 22.03.2018, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha stabilito che nei casi di mobbing orizzontale, ovvero quelle situazioni in cui il mobbing sia stato compiuto da un dipendente nei confronti di un suo collega, il datore che viene condannato a risarcire il dipendente vittima di mobbing può rivalersi nei confronti del dipendente autore delle condotte vessatorie.
Questa decisione è molto importante perché evidenzia una crescente sensibilità da parte della giurisprudenza sul tema delle persecuzioni sul luogo di lavoro posta in essere da alcuni dipendenti nei confronti dei loro colleghi.
Alcuni esempi di mobbing:
- Calunnie;
- Dispetti;
- Spregi;
- Pettegolezzi;
- Emarginazione o isolamento (c.d. ‘bullismo’);
- Umiliazione;
- Svalutazione dell’operato;
- Derisione.
In un altro interessante caso un lavoratore aveva criticato il collega e la propria azienda con un post pubblico su un famoso social network.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 maggio n.18717/2018, ha suggerito vari modi per difendersi e quindi per agire legalmente nei casi di mobbing orizzontale.
In primo luogo è opportuno riferire tali offese al datore di lavoro (mediante esibizione delle e-mail o whatsapp ingiuriosi, registrazione vocale delle minacce subite ecc.). Il datore di lavoro è responsabile per la salute psicofisica di tutti i dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. e quindi può adottare misure punitive (es. sospensione per alcuni giorni) o anche licenziare il dipendente offensivo se questi, ad esempio, danneggia l’immagine della propria azienda. Ove le offese, i dispetti, le mortificazioni sono continue è possibile anche agire contro il collega attraverso una causa di mobbing, per ottenere il risarcimento del danno e il licenziamento dello stesso autore delle condotte di mobbing.
Ove invece gli episodi vessatori siano sporadici o occasionali si potrebbe parlare di straining. In tali situazioni, come detto, è comunque prevista un’azione di risarcimento del danno. I giudici della Suprema Corte ritengono che che se la vittima è costretta a cambiare le proprie abitudini quotidiane per via del costante stress e per la paura del collega molesto che pone in essere vessazioni e umiliazioni continue, creando altresì un danno per la salute della vittima, può scattare anche una denuncia penale per stalking.
I giudici di Cassazione ritengono che sia responsabile anche il collega che parla male dell’altro collega (ledendo in modo specifico la sua reputazione), e lo fa in sua assenza e davanti altre persone (minimo due). La vittima può infatti sporgere querela per diffamazione alle forze dell’ordine e pretendere un risarcimento del danno. Va precisato che la diffamazione, in quanto illecito penale, può comunque comportare l’archiviazione del procedimento e la non applicazione della pena per la “particolare tenuità del fatto”.
Danno da “Straining”: la giurisprudenza ribadisce l’importanza di evitare situazioni “stressogene” sul lavoro.
Il datore di lavoro è “tenuto ad evitare situazioni “stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente” comportare un danno alla salute per il lavoratore, e ciò “anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio”, in virtù della natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., il quale impone al datore medesimo l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti. In questo senso, il suddetto stress forzato può derivare “dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo”, integrando il fenomeno del cd. straining.
La Corte di Cassazione ha così ribadito il consolidato orientamento in base al quale il datore di lavoro deve mantenere un equilibrio sul luogo di lavoro, evitando situazioni di “stress” potenzialmente dannose per i dipendenti.
(Corte di Cassazione, ordinanza 29 marzo 2018 n. 7844)
Sicurezza sul lavoro: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
Con la circolare n. 1 del 2018 l’INL chiarisce quale sia la corretta applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, dell’art. 34 T.U. Sicurezza sul lavoro relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
Il ruolo del datore di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che la concessione di tale facoltà al datore di lavoro (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio ex art. 31, comma 6) non comporta che questi svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore dall’art. 18 d.lgs. n. 81/2008.
Egli, previa adeguata formazione, può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, ma non in totale autonomia: si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure, che devono essere designati in numero adeguato e sufficiente, nel rispetto dell’art. 43, comma 2 del citato T.U..
Fonte: www.lavoropiu.info
Sicurezza sul lavoro: quali misure adottare?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure di sicurezza previste dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata che rappresentano lo standard minimo per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche quelle misure richieste dalla specificità dei rischi connessi tanto all’uso di macchinari quanto all’ambiente di lavoro. Se il datore, nell’esercizio dell’impresa, non provvede ad adottare tali misure ne risponde a titolo di responsabilità contrattuale.
Così ha stabilito in un caso recente la Sezione Lavoro della Cassazione, affermando che una struttura ospedaliera era tenuta al risarcimento del danno biologico all’infermiere aggredito da un paziente durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso. I giudici hanno precisato che l’art. 2087 del codice civile – Tutela delle condizioni di lavoro – prescrive espressamente all’azienda di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
In ogni caso, in tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, il lavoratore deve provare l’esistenza del danno ed il fatto che esso sia stato causato dalla mancanza delle opportune misure di sicurezza, così come il datore di lavoro deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o quantomeno di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedirlo.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 giugno 2017, n. 14566)
Cessazione dell’attività e procedura di licenziamento
Decisione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11404/17 depositata il 10 maggio 2017.
Il caso. La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui la società convenuta era stata condannata al risarcimento del danno pari a 12 mensilità patito da un lavoratore per il licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità avviata ai sensi della l. n. 223/1991. La procedura era viziata per non aver la società rispettato il termine di sette giorni previsto per la comunicazione alle OO.SS. di categoria l’avviso di apertura della procedura di licenziamento collettivo, adempimento osservato con ben due mesi di ritardo.
La società ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per la ritenuta essenzialità del termine di cui all’art. 4, comma9, L. n. 223/1991 in quanto versandosi in un caso di cessazione dell’attività con azzeramento dell’intero organico non sussisteva la necessità di comparazione tra lavoratori da licenziare.
Ratio. Alla luce dei costanti orientamenti giurisprudenziali, la Corte nega ogni fondamento alle suddette censure. Fermo restando che la scelta dell’imprenditore di cessare l’attività è coperta dalla libertà d’impresa di cui all’art. 41 Cost., la procedimentalizzazione dei conseguenti licenziamenti risponde alla ratio di consentire un controllo sindacale sulle ragioni effettive di tale scelta in modo da evitare comportamenti elusivi che possano ledere i diritti legislativamente riconosciuti ai lavoratori come nel caso in cui la cessazione dell’attività sia solo dissimulata e riprenda sotto diversa denominazione o in un diverso luogo.
La giurisprudenza riconosce dunque l’«assimilazione logica» della cessazione dell’attività alle ipotesi di licenziamento collettivo con applicazione della medesima procedura. Sulla base di tali premesse, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle OO.SS. nonché ai competenti uffici del lavoro richiesto a pena di inefficacia del licenziamento deve essere valutato rigorosamente «nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni», salvo giustificati motivi di natura oggettiva che devono essere dimostrati dal datore di lavoro.
Risulta dunque corretta l’argomentazione del provvedimento impugnato che ha dato rilevanza al mancato rispetto del termine di sette giorni per l’invio delle comunicazioni alle competenti organizzazioni sindacali.
Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: dirittoegiustizia.it