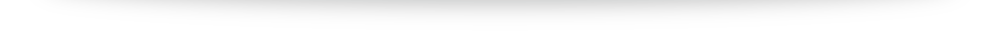Il diritto di controllo e ispezione del socio, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può sopravvivere all’estinzione dell’ente, trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata. (Tribunale Milano, 22/04/2022).
In ipotesi in cui la società a responsabilità limitata sia una holding non può affermarsi, in via generale ed astratta, la sussistenza del potere del socio di esaminare indifferentemente e direttamente ogni documento della partecipata, ma non può per converso negarsi in radice la possibilità di avere specifiche informazioni sulle partecipate, se si negasse tale facoltà si avrebbe come risultato lo svuotamento del diritto ex art 2476 comma 2 c.c. ogni volta in cui la società abbia come attività soltanto quella “statica” di gestione di partecipazioni.
Il contrasto tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale “comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori- laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476, comma 2, c.c. – si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società. (Tribunale Milano, 29/04/2022).
Fonte: ilsocietario.it