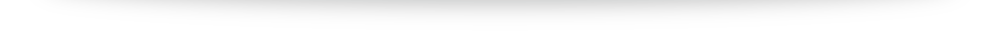Cass. Civ. – Sez. I – 19 maggio 2020, sent. n. 9139
Trasferimento della partecipazione in società di persone
In tema di trasferimento della partecipazione in società di persone, l’accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Nel caso di specie due coniugi erano soci di una società semplice, proprietaria di un immobile; dopo la separazione dalla moglie, il marito aveva chiesto a quest’ultima di trasferirgli la quota che, in base all’accordo intercorso durante il matrimonio, le era stata intestata provvisoriamente, posto che il corrispettivo della cessione era stato pagato con denaro del marito, che aveva altresì assunto in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Stante il rifiuto opposto dalla moglie al trasferimento della quota, il marito adiva il Tribunale di Torino, che respingeva la domanda.
All’esito del giudizio di gravame, la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado, accertando l’obbligo della moglie di trasferire al marito la quota di partecipazione detenuta nella società semplice.
La moglie quindi ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino.
Le contestazioni della moglie, risultata vittoriosa all’esito del primo grado di giudizio ma soccombente in quello di appello, riguardavano la forma dell’accordo: secondo la ricorrente, infatti, il pactum fiduciae avente per oggetto la cessione di quote societarie necessita dell’atto scritto, sicché quello concluso dai coniugi, non rivestendo tale forma, non poteva essere considerato valido ovvero opponibile.
A maggior ragione, secondo la ricorrente, l’onere formale doveva essere osservato in considerazione del fatto che la società delle cui quote si discuteva era proprietaria di un immobile, sicché – in realtà – le parti, con l’accordo fiduciario, avevano inteso pattuire il trasferimento di detto immobile dalla moglie al marito, onde fargliene acquistare, in questo modo, la proprietà.
La Corte di cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente.
La decisione della Corte di cassazione è pienamente condivisibile, vieppiù a seguito del consolidamento – in virtù del recentissimo arresto delle Sezioni Unite – dell’orientamento che vede nel pactum fiduciae non già un contratto preliminare, ma una fattispecie di mandato senza rappresentanza, che costituisce lo strumento tipico dell’agire per conto altrui e si pone come la figura negoziale più idonea per realizzare l’intento delle parti di fare acquistare a un soggetto un bene mediante la provvista di un altro, con l’impegno ad attenersi poi alle istruzioni da questo impartite ovvero a ritrasferire successivamente la proprietà del medesimo bene.
Al contrario del preliminare (in cui l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale e lo precede), nel contratto fiduciario l’effetto reale si produce immediatamente (con l’acquisto della proprietà da parte del fiduciario) e su di esso si innesta l’effetto obbligatorio (ossia il vincolo del fiduciario alle istruzioni del fiduciante e, in particolare, alla futura esecuzione di un atto traslativo che impedisca il consolidamento di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante, posto che al pactum fiduciae deve reputarsi estraneo qualsiasi intento liberale del fiduciante e che la posizione di titolarità creata in capo al fiduciario si rivela soltanto provvisoria e strumentale al successivo ritrasferimento).
Per quanto, peraltro, l’accordo fiduciario non debba essere concluso per iscritto a pena di nullità, è evidente che la sua documentazione (al limite, anche per il tramite di dichiarazioni ricognitive unilaterali) risulta comunque consigliabile, onde evitare che, a fronte del rifiuto del fiduciario di ottemperare all’impegno assunto, il fiduciante si trovi nella pratica impossibilità di provarne l’esistenza e il contenuto.
Fonte: ilsocietario.it